
 La Lavagna Del Sabato 13 Luglio 2013
La Lavagna Del Sabato 13 Luglio 2013 LA MENZOGNA DELL'INDIVIDUALISMO
Aldo Marchetti

Individualismo e neoliberismo
Una menzogna ci accompagna da trent'anni: poderosa e insinuante. Poderosa perché ambisce a disegnare il nostro futuro e insinuante perché attraversa lo spazio in ogni direzione e usa tutti i canali di comunicazione in modo costante e soffuso. Nessuno l'ha espressa in modo così icastico come la signora Thatcher agli inizi degli anni '80 quando ha proclamato: «La società non esiste, esistono solo gli individui». Sembrava una battuta ed era invece il grido di battaglia di una concezione del mondo, di un nuovo pensiero che pretendeva di diventare egemone. Questa frase, come una breve formula cerimoniale, intendeva santificare il matrimonio tra individualismo e neoliberismo. I due termini infatti vanno considerati assieme come le due facce di un unico fenomeno. L'individualismo di mercato non è che il risvolto antropologico del neoliberismo come dottrina economica. La Thatcher, fervente neoliberista, che in un solo decennio ha rivoltato come un calzino l'economia inglese (ma non ha dovuto faticare troppo se diamo ascolto al sociologo inglese Ronald Dore, quando afferma che quel paese, a dispetto delle incursioni nel welfare di stato operate negli anni '50, resta il più individualista del mondo) aveva anche capito che la dottrina a lei cara doveva penetrare nei comportamenti quotidiani e diventare culturalmente dominante. E così è avvenuto poiché se il neoliberismo, che nella crisi che stiamo attraversando ha palesato al mondo tutta la vacuità del suo progetto, sopravvive senza gravi scossoni al suo fallimento, è perché non trova più, almeno nelle metropoli della vecchia economia, nessuna terapia che faccia regredire la metastasi del pensiero che ha provocato.
Menzogna doppia poiché fa passare per universale e, per così dire, naturale, un progetto di società che è invece frutto di una scuola ideologica storicamente determinata e perché impone che ciò che è solo una parte diventi l'intero: esige, in altre parole, che tutte le persone si conformino alle attitudini di poche.
Il neoliberismo non è orfano e non soffre la solitudine: ha padri, padrini e padroni. Per un'ironica ma non rara avventura delle parole il termine fu coniato da Alexander Rüstow, un sociologo tedesco di convinzioni socialiste fuggito dalla Germania nazista che auspicava una riforma del vecchio liberalismo in direzione di un maggior coinvolgimento dello stato come regolatore dell'economia. Curiosamente fu poi utilizzato dall'economista dell'Università di Chicago, Milton
Friedman che, diventato consulente economico del dittatore cileno Pinochet, suggerì una politica del tutto diversa, fondata sulla deregolamentazione economica, la riduzione della spesa pubblica e l'abolizione del tanto odiato sistema di welfare statale. Il neoliberismo interviene nella vita collettiva facendo del sociale una funzione dell'impresa e organizzando la libertà solo come libertà in negativo cioè come assenza di ostacoli per la vita economica. Si tratta di conformare la società intera ai principi su cui si regge l'attività imprenditoriale cioè su relazioni fondate sull'accumulazione e la concorrenza.
Nella concezione neoliberista del mondo l'individuo deve diventare una rotella del meccanismo della vita economica. Destituito dei suoi connotati sociali deve ridursi a homo oeconomicus secondo le diverse declinazioni del termine: imprenditore, produttore, consumatore, debitore, creditore, proprietario. Quelle funzioni che già Nietzsche nella Genealogia della morale aveva identificato come gli elementi costitutivi dell'uomo civilizzato e soggiogato cioè «prevedibile, regolare, calcolabile». Tutto ciò che è comunitario o collettivo (associazioni, sindacati, partiti, comunità di interessi, cooperative, gruppi) rappresenta per il progetto neoliberista un'inutile e anacronistica zavorra.
La privatizzazione e l'introversione dell'individualismo di mercato hanno molteplici facce ormai così pervasive da essere percepite come ovvie e necessarie. Passano per la conclamata (per quanto superficiale) personalizzazione dei consumi, così come per la continua diffusione della paura e la sollecitazione dell'istinto di difesa (i complessi residenziali sono trasformati in castelli medioevali con recinti, torrette, posti di guardia e controlli a distanza; il design delle auto-mobili di ultima generazione è uniformato ormai a un modello di piccolo fortilizio semovente con frontali aggressivi, fiancate sempre più alte, finestrature piccole, sfuggenti e col vetro affumicato, gli esterni di una sconsolante ripetitività ma compensati da interni sempre più finemente curati). Ma soprattutto l'uomo neoliberista deve diventare imprenditore di se stesso.
Bisogna ammettere che la figura dell'imprenditore non ha goduto di buona letteratura. Il sospetto che la sua ricchezza sia stata accumulata sulla miseria degli altri non è mai stato dissipato. I modelli letterari prevalenti sono quelli dei cadenti Buddenbrook, dipinti dall'ironia del giovane Mann, degli avventurieri cinici e spericolati rievocati dallo storico Braudel, degli affaristi insonni del sociologo Veblen, degli avidi e immorali profittatori di guerra di Arthur Miller (Erano tutti miei figli), dei cupi padroni delle ferriere di Dickens (Hard Times), degli ambigui industriali, compromessi con il nazismo, di Sartre (I sequestrati d'Altona), piuttosto che quelli dei prometeici innovatori celebrati da Schumpeter. Ma tutto questo sembra non contare più niente. Oggi i nipotini dei Fugger (tessuti), dei Rockefeller (petrolio), dei Krupp (cannoni) e dei Dupont (polvere da sparo) ci mandano a dire che il tempo delle chiacchiere è finito, che sono loro a tener banco e a dettare le regole del gioco e che, volenti o nolenti, tutti noi dobbiamo assumere le loro sembianze. Si badi, non siamo invitati ma costretti a diventare imprenditori (se non di altri almeno di noi stessi) e dobbiamo anche farlo in fretta perché rischiamo di uscire dal mercato o di non entrarci mai.
I Robinson: gli uomini che si fanno (e si disfano) da sé
Robinson Crusoe è il prototipo dell'imprenditore di se stesso e allo stesso tempo, privato di ogni rapporto sociale dopo il naufragio su un'isola deserta, incarna alla perfezione l'individuo economicamente orientato, vagheggiato dalla signora Thatcher. Non se la cava male. Percorre da solo l'intera storia della civilizzazione umana diventando prima raccoglitore e cacciatore, poi allevatore e agricoltore e infine artigiano. Il Robinson di Defoe (non bisogna dimenticare che l'autore scrisse anche di economia e fu uno dei testimoni più consapevoli delle profonde trasformazioni vissute dall'Inghilterra nel periodo che precedette la rivoluzione industriale), come un bravo commerciante, accumula quanto più è possibile sino a dar corpo al «più grande magazzino di oggetti diversi che mai sia stato ammassato da un uomo solo», ama gli elenchi e fa continui inventari dei propri averi, sente acuto il problema della sicurezza e sta a suo agio solo in mezzo alle sue ricchezze, vive frugalmente e fa persino un bilancio scritto su due colonne di quelli che definisce i suoi «affari» ma che sono in realtà gli aspetti positivi e negativi della sua nuova condizione di naufrago, posti a confronto tra loro come il dare e l'avere in un registro a partita doppia. Sin dall'inizio comincia a misurare il tempo con delle tacche che incide ogni giorno su una tavola di legno e regola la sua giornata secondo «orari di lavoro, di uscita, di ricreazione, di riposo». Nel suo ponderare solitario si convince che «le buone cose dell'universo sono buone soltanto per l'uso che ne facciamo e ne possiamo godere solo nella misura in cui ci servono o in cui le accumuliamo per donarle agli altri e nulla di più». Ma non è solo l'intatta e stupefacente natura che lo circonda ad essere al suo servizio. Quando Robinson scorge da lontano una creatura in fuga braccata dai cannibali (che diventerà Venerdì) il primo pensiero che gli balza in mente è che quella è l'occasione buona per procurarsi «un servo, un aiutante, forse un compagno». Sarà senza dubbio un servo. Infine evaso dalla sua isola e recuperato alla civiltà, Robinson, per i miracoli dell'economia finanziaria, riuscirà a rientrare in possesso dei titoli di proprietà di una sua vecchia piantagione brasiliana il cui valore si era moltiplicato nel frattempo grazie agli interessi composti e concluderà la vita con agio nel suo paese di nascita.
Ne La strada di Cormac McCarthy la favola di Defoe trova il suo epilogo. In un mondo completamente distrutto da un cataclisma di cui si ignora la causa (gli stessi protagonisti non sanno se è stato provocato dagli uomini o dalla natura) un uomo e il suo bambino, naufraghi senza nome, procedono tra boschi inceneriti e città ridotte a cumuli di macerie andando verso sud, alla ricerca di luoghi più caldi e nutrendosi solo di vecchio cibo in scatola trovato nei casolari ormai distrutti e abbandonati. Nella loro angosciosa marcia i due naufraghi si imbattono in altri superstiti soli o raccolti in gruppi, armati, affamati, diffidenti, in guerra gli uni contro gli altri per accaparrarsi le rare risorse rimaste. Nel suo libro McCarthy non dichiara alcun debito verso il Robinson di Defoe e tuttavia le somiglianze sono numerose e per alcuni versi del tutto evidenti: le scene di cannibalismo, l'ostilità della natura, gli elenchi reiterati degli oggetti che si hanno e di quelli che mancano, l'ossessivo rimando alla natura e alle sue più pericolose manifestazioni. La scena finale del libro infine ricalca in modo sorprendente quella iniziale del romanzo di Defoe. L'uomo-naufrago, giunto in riva al mare scorge il relitto di una barca, lo raggiunge e procede in più viaggi a saccheggiarlo di tutto quello che di utile ci trova, elencando minuziosamente gli oggetti e i generi alimentari ancora commestibili. Ma, appunto, ciò che era al principio per Robinson ora è alla fine: la parabola dello sfruttamento del pianeta, della produzione intensiva e dell'accumulazione delle ricchezze si è interamente compiuta. Il mondo è esausto e sterile e la società è morta con lui. L'uomo è ormai un individuo nel senso più tragico della parola perché è solo.
Esiste un terzo Robinson e questa volta conserva il proprio nome. È quello di Michel Tournier (Venerdì o il limbo del Pacifico) che per alcuni versi cerca d'imitare il suo più celebre precursore: va a caccia, alleva le capre, accumula quanto può, si costruisce un confortevole rifugio. Con riluttanza si convince anche a misurare il tempo e si costruisce una rudimentale clessidra. Ma questa volta il naufrago sente anche i morsi della solitudine, rischia la follia, soffre per la mancanza dei rapporti sessuali, si chiude nel profondo della sua piccola grotta come nel grembo di una madre, cerca di ricostruire nella fantasia («seguendo lo sbocciare timido, sulle prime, di tendenze quasi inconsce») quella società che non ha più, dando all'isola una costituzione e un codice penale, mettendo a punto un complesso cerimoniale che rispetta poi rigorosamente, inaugurando un padiglione dei pesi e delle misure, un palazzo di giustizia e un tempio. Nel complesso quindi il Robinson II° non riesce a diventare un buon Robinson I°. Quando la clessidra si rompe scopre con meraviglia che «era possibile sfuggire all'implacabile disciplina del tempo» e il suo diario non lo usa tanto per narrare i fatti quotidiani, come il suo predecessore, quanto per fissare le sue meditazioni, essendo stato trasformato dalla solitudine più in un filosofo che in un affarista. Quando Robinson II° incontra il suo Venerdì sulle prime lo tratta come un servo, cerca di domarlo e ammaestrarlo, ma finisce sol capire che si trova di fronte a una irriducibile diversità «Robinson si vide costretto a confessarsi che, sotto la docilità premurosa di Venerdì, si celava una personalità e che ogni emanazione di questa, oltre ad urtarlo profondamente, rappresentava un rischio per l'integrità dell'isola amministrata». E tuttavia dovrà modificare ulteriormente la sua convinzione. In un gesto inconsulto Venerdì getta una pipa accesa nella santa barbara gelosamente custodita dal suo padrone. Quaranta barili di polvere da sparo esplodono squassando l'intera isola. Il fragile equilibrio economico di Robinson salta in aria con loro: le greggi scappano dai recinti infranti, i raccolti bruciano, il suo rifugio viene distrutto con tutti i beni che custodiva. Come conseguenza del cataclisma, in un ambiente tornato selvaggio, il buon Venerdì dimostra di avere le arti sufficienti per cavarsela molto meglio del padrone civilizzato. I rapporti si invertono: è Robinson II° ora che deve imparare dal suo allievo e lo fa dimostrando una certa dose di insospettata umiltà. Nei confronti di Venerdì comincerà a nutrire un sentimento di fratellanza e alla fine non saprà nemmeno «chi dei due è il fratello maggiore». Rimasta intatta la sua propensione al meditare lo colpiranno «in mezzo al viso come uno schiaffo benefico» alcuni versetti della Bibbia «Ma guai a colui ch'è solo e cade senz'avere un altro che lo rialzi».
Il pensiero neoliberista non è l'unico pensiero. A cominciare dallo stesso concetto di libertà. Secondo Amartya Sen la libertà va considerata come insieme di opportunità di progettare e costruire una vita in cui poter esprimere e assecondare le proprie propensioni e capacità. È una visione in positivo che si oppone a quella del neoliberismo poiché mette al centro la persona e la vita sociale ai quali l'attività economica deve essere subordinata. Ma anche solo nell'ambito della vita produttiva e di consumo le sempre più numerose esperienze di cooperazione e di economia sociale (molto diffuse ovunque e in modo particolare in America Latina, un continente che nel suo insieme si è di molto allontanato dalle politiche neoliberiste), ci indicano una strada diversa e feconda. Queste esperienze ci dimostrano che è possibile contrapporre la solidarietà alla competizione, la collaborazione alla concorrenza, il rispetto della natura al suo sfruttamento indiscriminato, la ragionevolezza nel rispetto degli altri alle razionalità del calcolo economico, il benessere collettivo al profitto privato. C'è vita oltre il neoliberismo.
Articolo tratto dalla rivista “Il Segnale” n° 95, di Luglio 2013.
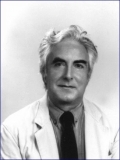
Aldo Marchetti è nato nel 1946 e si è laureato in filosofia all’Università degli studi di Milano. Negli anni 1972-73 ha seguito il corso biennale di specializzazione presso la Scuola di formazione in sociologia (Cospos) di Milano, diretta dal professor Alessandro Pizzorno, con relativa borsa di studio messa a disposizione dal Consiglio nazionale delle ricerche. Dal 1983, dapprima in qualità di cultore della materia e — successivamente — di professore a contratto, collabora, presso la Facoltà di scienze politiche dell’Università di Milano, con la cattedra di sociologia del lavoro e dell’industria. Ha svolto altresì attività didattica alla Facoltà di economia dell’Università di Brescia e alla Facoltà di sociologia di Milano (Bicocca). Ha partecipato nel 1989-90 al Progetto strategico Cnr “Il conflitto e le relazioni nel decennio Novanta” con due ricerche sotto la direzione del professor Tiziano Treu e del professor Giuliano Urbani. Nel 1991-92 ha svolto per la Società “Metodo” di Milano una ricerca sulla condizione di impiego del personale della scuola in Francia, Spagna e Belgio, commissionata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana (Dipartimento della funzione pubblica). Ha collaborato (con numerosi saggi di storia, di sociologia e di attualità politica) alle riviste specializzate «Problemi dell’informazione», «Ikon», «Quaderni di rassegna sindacale», «Proposte», «Economia e lavoro», «Azimut», «Classe», «Prospettive sindacali», «Storia in Lombardia», «Iter». È attualmente direttore responsabile della rivista di filosofia, arte e poesia «La Mosca di Milano». Tra le sue tante pubblicazioni, quelle più significative riguardano temi di antropologia (Un teatro troppo serio. Appunti di analisi del corteo operaio e dello slogan politico di strada, «Classe», n. 21, 1978), di storia (Alla ricerca della rivoluzione introvabile. Prolegomeni a futuri studi sulle rivolte studentesche del 1968, «Classe. Il sociale e l’immaginario», n. 2-3, 1988), di sociologia (Tra due rive. La nuova immigrazione a Milano, con Giuseppe Barile e Alessandro Dal Lago, FrancoAngeli Edizioni, Milano, 1994; Omaggio alla donna khmer. La condizione femminile in Cambogia dal periodo di Pol Pot agli anni della democrazia, «Quaderni asiatici», n. 69, 2005).
