|

 UN’INTERVISTA
CON STUART HALL
UN’INTERVISTA
CON STUART HALL
Heloisa Buarque de Holanda e Liv Sovik
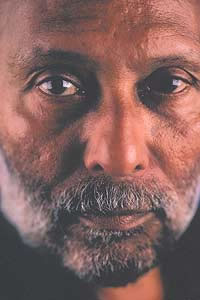 Stuart
Hall è oggi, in Brasile, uno dei nomi più riconosciuti
della cultura accademica. Tra i promotori della polemica “post-disciplina” degli
studi culturali, Hall ha diretto lo storico Centro di Birmingham
nel suo periodo più caldo e produttivo. Giamaicano,
dal 1951 vive in Inghilterra, dove è noto come intellettuale
impegnato nei dibattiti sugli aspetti politico-culturali della
globalizzazione, sulla politica nazionale e i movimenti antirazzisti.
Ha pubblicato due libri in Brasile: “A identidade cultural
na pós-modernidade” (“L’identità culturale
nella post-modernità”) e “Da diáspora” (“Sulla
diaspora”). In quest’intervista, Hall parla dell’impatto
della sua condizione di immigrante sulla sua produzione intellettuale
e sulle prospettive dell’impegno intellettuale oggi,
e discute come sia possibile elaborare criticamente la globalizzazione. Stuart
Hall è oggi, in Brasile, uno dei nomi più riconosciuti
della cultura accademica. Tra i promotori della polemica “post-disciplina” degli
studi culturali, Hall ha diretto lo storico Centro di Birmingham
nel suo periodo più caldo e produttivo. Giamaicano,
dal 1951 vive in Inghilterra, dove è noto come intellettuale
impegnato nei dibattiti sugli aspetti politico-culturali della
globalizzazione, sulla politica nazionale e i movimenti antirazzisti.
Ha pubblicato due libri in Brasile: “A identidade cultural
na pós-modernidade” (“L’identità culturale
nella post-modernità”) e “Da diáspora” (“Sulla
diaspora”). In quest’intervista, Hall parla dell’impatto
della sua condizione di immigrante sulla sua produzione intellettuale
e sulle prospettive dell’impegno intellettuale oggi,
e discute come sia possibile elaborare criticamente la globalizzazione.
-Lei
ha lasciato la Giamaica quando era ancora uno studente, e oggi è uno
degli intellettuali più importanti dell’Inghilterra.
Suppongo che questo trasferimento dalla colonia alla metropoli
abbia segnato il suo pensiero e la sua attuazione.
-In realtà questa per me è una storia critica.
Tutto ciò che è avvenuto quando ho preso la decisione
di non tornare più in Giamaica, ha determinato il mio
destino e certamente anche le mie preoccupazioni intellettuali.
Ho lasciato la Giamaica dieci anni prima della sua indipendenza.
Tutta la mia formazione è dunque avvenuta in un contesto
coloniale. La mia storia era quella di un ragazzino che si trasferisce
dalla colonia verso il centro della metropoli, verso il luogo
dei colonizzatori: un’esperienza diversa dal contesto degli
anni Settanta, Ottanta e Novanta, dalla lotta dei neri contro
il razzismo in Gran Bretagna. Ormai vivo in Inghilterra da più di
cinquant’anni, ho sposato un’inglese, i miei figli
sono nati in Inghilterra, e oggi vedo un paese diverso. Quella
di oggi è un’Inghilterra multiculturale, ma il mio
rapporto con lei è lo stesso. Conosco l’Inghilterra
e gli inglesi come il palmo della mia mano, ma non mi considererò mai
un inglese. Per quanto riguarda la Giamaica, è il mio
paese perduto, in cui ormai non mi sento più a casa. La
Giamaica è ciò che avrei potuto essere stato, è ciò che
sarebbe potuto accadere. Se la Giamaica fosse stata una società nera
quando sono partito, non sarei mai rimasto in Inghilterra. Sarei
tornato a casa. Non mi sento a casa in nessuno dei due Paesi,
e questo, suppongo, a causa della mia enfasi nei riguardi del
concetto di in betweenness. È per questo che mi interesso
al fenomeno delle diaspore, alle ibridazioni, a ciò che
si definisce “casa”, verso cui non si ritorna mai
effettivamente.
-Quale
potrebbe essere il parallelo tra la diaspora giamaicana e quella
afro-brasiliana?
-Ci ho pensato molto. In realtà, intendo una doppia diaspora,
un’esperienza di doppia subordinazione. La prima relativa
alla schiavitù intellettuale, la seconda relativa all’esperienza,
nella grande città, della discriminazione razzista e coloniale.
E si tratta di due forme ben distinte di subordinazione. Questa
duplice esperienza ci rende esperti in allontanamenti “diasporici”.
Dobbiamo adattarci infinitamente a culture più potenti.
Impariamo qualcosa con la prima esperienza, che ci è utile
per la seconda che avviene negli anni successivi e per quella
che sta avvenendo adesso nel contesto della globalizzazione,
e così via all’infinito.
-Lei è stato
assistente di Richard Hoggart quando fu fondato il “Center
for Contemporary Cultural Studies” a Birmingham, e quando,
poco dopo, ne è diventato direttore. Come si sente essendo
stato praticamente il “fondatore” degli studi culturali,
disciplina oggi così polemica?
-Quando abbiamo creato il Centro, gli studi culturali non esistevano
e non era tra i nostri progetti crearli. Cercavamo soltanto di
aprire un’area di ricerca e di studi critici. Penso che
gli studi culturali appartengano ad un’area polemica perché questa
disciplina è sempre attenta a ciò viene fatto nelle
altre e a ciò che si può dedurre da quelle a livello
culturale. Non mi sento il padre degli studi culturali, io non
ho creato il Centro. Abbiamo lavorato con figure quali Edward
P. Thompson, Richard Hoggart e Raymond Williams, più anziani
di me, più studiosi della cultura di me…Gli studi
culturali non sono nati da soli. Sono sorti in relazione ad altri
movimenti dell’epoca, come le politiche culturali, il femminismo,
gli studi multiculturali, soprattutto gli studi post-coloniali,
insomma, una gamma di nuovi lavori critici sulle scienze umane.
-Lei
ha cominciato la sua attività critica nella letteratura,
in polemica con il canone letterario, poi si è aperto
verso studi generali sulla cultura e ora vediamo un interesse
verso le arti visive. Come è avvenuto questo spostamento
di interessi?
-Sono diventato studente di letteratura perché volevo
essere uno scrittore. A Oxford, dove mi sono formato, odiavo
il clima di dilettantismo che là imperava, e divenni un
critico letterario ferocissimo nei confronti della linea canonica
di F.R Leavis. Fu in quella circostanza che cominciai a lavorare
sul rapporto tra il testo letterario e il contesto storico e
sociale. Nello stesso tempo ero già un modernista. Ciò che
mi stimolava come scrittore era leggere T.S. Eliot ed Ezra Pound,
ascoltare Stravinski, vedere Paul Klee, Ricasso, e ad Oxford
dovevo studiare la lingua anglosassone del Medioevo e in letteratura
fortunatamente, arrivavo fino al XIX secolo. Fu a quel punto
che, leggendo F.R. Leavis, il new criticism americano, e affrontando
Raymond Williams e la critica sociale, cominciai a capire che
lo studio della letteratura richiedeva soprattutto la comprensione
di un contesto storico e culturale più ampio. Cominciai
anche a frequentare giovani autori caraibici che erano arrivati
a Londra, come ad esempio George Lamming e V.S. Naipaul. Quando
cominciai la specializzazione, pensai: quello che devo fare è capire
la differenza tra la cultura caraibica, da dove proviene, e quest’altra
cultura che produce testi magnifici che sono studiati isolatamente,
all’interno di un canone. Questo mi ricondusse indietro
ai Ciraibi. Gli studi culturali, pertanto, sono cominciati con
il mio interesse per le culture diasporiche dei Carabi. È stato
lì che sono passato dalla letteratura alla cultura. Cominciai
a studiare i media e a scrivere su immagine e ideologia. È stato
il mio interesse per l’immagine che mi ha portato al mio
attuale interesse per le arti visive. E più recentemente
ho cominciato a lavorare sul primato del visivo nel discorso
del razzismo, perché, sebbene la sua struttura di base
non lo sia, la sua apparenza immediata è una questione
visiva, ciò che si può vedere.
-
In questo momento a Rio è in corso un dibattito sulla
correttezza o meno dell’istituzione di una franchigia
dei musei Guggenheim. Come vede questa espansione “imperialista” dei
musei nel mondo?
- Curatori di Mosca, L’Havana e altri luoghi, stanno discutendo
la relazione tra i Paesi in via di sviluppo e questo circuito
milionario in cui il lavoro artistico è valorizzato, riprodotto,
acquista un valore commerciale enorme nel mercato dell’arte
e diventa produttore di reputazioni artistiche nei centri più prestigiosi
nel mondo. Questa democratizzazione dell’arte e del fare
artistico è, certamente, abbastanza positiva e progressista,
ma il tipo di rapporto che l’espressione “tempo libero” stimola, è molto
passivo. I musei sono diventati parte di un circuito fashion.
Non propongono sfide attraverso grandi contestazioni. Ben vengano
i musei! Tuttavia, se spettacolarizzano il passato, tradiscono
la loro missione contemporanea.
-Parliamo
ora un poco a proposito del suo nuovo libro pubblicato in Brasile,
Da Diáspora: identidades e mediações culturais (La diaspora: identità e mediazioni culturali), che
si è esaurito in quattro mesi, un record per una pubblicazione
accademica. In precedenza lei aveva già un best
seller in Brasile, A identidade cultural
na pós-modernidade (L’identità culturale nella post-modernità).
Come considera il successo dei suoi testi in Brasile?
- Innanzitutto questo successo è tanto inaspettato quanto
incredibile. Sono molto felice di ciò. Ci ho pensato,
e forse questo successo è dovuto al fatto che il Brasile
ha un rapporto con le culture europee molto simile a quello con
i Caraibi. E questo è il tema soggiacente a quasi tutte
le mie opere. È ciò di cui parlo quando tratto
di ibridazione, di “creolizzazione”, di diaspora.
Credo che, in Brasile, le persone si sentano molto toccate da
questa tematica.
-
Lei non si dichiara mai l’autore delle opere che pubblica.
Sono sempre stati altri che hanno preso l’iniziativa
di raccogliere insieme i saggi e di pubblicarli. Perché?
- Perché io non scrivo libri. Scrivo saggi. E non scrivo
mai pensando alla pubblicazione. I miei scritti nascono in funzione
di situazioni concrete, sono sempre interventi. Cercano sempre
di ri-direzionare una certa situazione. Allora, generalmente
scrivo e pubblico per riviste legate a movimenti sociali, culturali
o artistici legati ai temi che tratto. Soltanto molto dopo questi
finiscono per essere riediti o tradotti e trasmessi a circuiti
più vasti. D’altra parte, non sono specializzato
su alcun argomento. Sebbene presentino un interesse comune, i
miei scritti affrontano temi molto diversi. Non ho scritto, ad
esempio, una teoria su Chris Ofili per il suo catalogo. Ho scritto
sull’arte africana. Poi, a partire dalla mia partecipazione
al programma del “Documenta de Kassel”, ho scritto
sulla creolizzazione. Ho appena scritto su Tony Blair e il New
Labour per la rivista Soundings, perché voglio intervenire
sulla situazione dell’Inghilterra di oggi. È in
questo modo che avverto l’atto di scrivere e di pubblicare.
E questo, all’inizio, non porta al libro…
-
Che ruolo deve avere l’intellettuale di oggi?
- Questo sì che richiederebbe un libro. Credo che essere
intellettuali oggi corrisponda al dire la verità per il
potere. È pensare alle conseguenze del potere, a quello
che il potere non vuol trattare, a quello che costituisce l’inconscio
del potere. Questi sono gli intellettuali critici. I veri intellettuali
o sono allineati col potere, nel tentativo di aprirgli il cammino
nel mondo, o hanno un rapporto critico col potere e devono metterlo
alla prova, interrogarlo, e soprattutto, esporre le proprie conseguenze
spropositate o incoscienti.
-
Come si può, oggi, articolare esperienza e conoscenza?
- Non credo affatto nell’obiettività della conoscenza.
Non credo che l’obiettivo della conoscenza sia la vittoria
della “nostra parte”. Gli intellettuali critici devono
essere intellettuali migliori rispetto agli intellettuali tradizionali,
devono mettere alla prova il proprio sapere, le proprie argomentazioni,
la propria posizione, per far fronte alle critiche che fatalmente
arriveranno e che possono distruggere l’efficacia del loro
lavoro. Il lavoro intellettuale, per affrontare i tempi nuovi,
deve essere critico, resistente, di qualità, e produrre
nuova conoscenza.
-
Che cose può esser fatto in queste circostanze instabili?
Quali strumenti sono ancora validi per il critico di cultura
nel quadro della globalizzazione?
- Ritengo che la globalizzazione ponga questioni urgenti. Tornano
a galla questioni che le teorie della moda avevano scartato,
come l’economia, il capitale, il capitalismo, le Forze
Armate, le armi di distruzione di massa, la religione, il suicidio,
i fondamentalismi, identità chiuse. Questioni come queste
tornano in scena e la globalizzazione le raggruppa nella misura
in cui genera le articolazioni del potere egemonico.
-
Lei si vede come teorico, critico di cultura o intellettuale
militante?
- Non sono un teorico perché non ho la testa per questo
e neanche mi interessa fare teoria. Faccio un lavoro intellettuale
teoricamente informato. Il mio obiettivo è usare la teoria
per analizzare le congiunture. Non mi sento nemmeno un intellettuale
militante. Sono un intellettuale attivista nel senso che ho sempre
voluto che il mio lavoro sottolineasse una differenza, registrasse
e condividesse dibattiti, contribuisse a cambiare una congiuntura,
cambiasse gli orientamenti degli interessi o delle forze politiche.
In questo senso sono un attivista. Sono anche un critico di cultura,
ma questo appare molto lontano dal campo di battaglia. Non sono
mai stato così coinvolto come adesso, quando penso all’attuale
congiuntura mondiale. Personalmente sono molto turbato da ciò.
Grido alla televisione, protesto per radio, davanti alle telecamere.
Non voglio che il dibattito continui come è stato sinora.
Vedo che le disuguaglianze tra il Primo e il Terzo mondo, tra
il Nord e il Sud, si stanno soavemente assimilando, e voglio
gridare. Non sono un politico, non sono un giornalista; dipendo
dal mio lavoro intellettuale perché la mia critica diventi
politicamente attiva.
-
Il suo lavoro sulle diaspore sta in qualche modo contribuendo
alla sua critica sulle disuguaglianze nel quadro della globalizzazione?
- C’è una globalizzazione dall’alto verso
il basso, neoliberale, e una globalizzazione dal basso verso
l’alto. In generale si dice che coloro che si oppongono
alla globalizzazione dall’alto verso il basso, siano “anti-globalizzazione”.
Non sono contrario alla globalizzazione per se. L’interdipendenza
tra le nazioni è vitale, è una fonte di enorme
creatività, così come di difficoltà e di
problemi. Un punto di grande interesse che vedo come conseguenza
dell’accettazione della globalizzazione di carattere neoliberale, è la
nascita di movimenti di dislocamenti laterali. Oggi il mondo è pieno
di persone in movimento che si ribellano alle guerre civili,
alla fame, alle malattie, alla xenofobia, alla povertà.
Questo è un tipo di globalizzazione informale, illegale.
Questa forma di globalizzazione laterale non è una questione
di potere. Questa è un contro-potere. Per il potere, non
ha senso che un pachistano si trasferisca a Los Angeles dove
devono dargli 50$ al giorno. Se lui resterà lì,
riceverà 2$ per lo stesso lavoro. La migrazione che ha
dato luogo a questa mescolanza di culture in tutto il mondo,
ha creato città multiculturali, ha creato nuove diaspore
nel resto del mondo. In tal modo la diaspora diviene un concetto
critico nel contesto politico della globalizzazione. Dà conto
di come sia possibile che una cultura sopravviva, stabilisca
rapporti, non si rivolga a difese fondamentaliste né si
perda diventando un simulacro e un complice dell’Occidente.
In questo senso le diaspore sono uno straordinario laboratorio
culturale in cui si sperimentano i tentativi di sopravvivenza
e le contronegozziazioni.
(Pubblicato
sul Suplemento Idéias del Jornal do Brasil, Gennaio
2004. Traduzione dal Portoghese di Sara Favilla)

 Precedente
Precedente  Copertina
Copertina
|