|

 AUTORITRATTO POETICO
AUTORITRATTO POETICO
 José Lezama Lima José Lezama Lima
Per me la notte era qualcosa che cadeva sulla terra, una discesa. La sua lentezza mi impediva di paragonarla a qualcosa che scendesse da una scala, per esempio. Una marea sopra un'altra marea e così via, ininterrottamente, fino a lambirmi i piedi. Collegavo la caduta della notte con la distesa unica del mare.
I fari delle automobili illuminavano percorsi a zig–zag e si udivano i primi “chi va là?”, si rincorrevano le voci da una postazione all'altra. La notte cominciava a popolarsi, a nutrirsi. Da lontano, la vedevo come attraversata da punti di luce incessanti. Suddivisa, frammentata, crivellata dalle voci e dalle luci. Era lontana, e sentivo soltanto i segni della sua animazione, come un mormorio segreto in una taverna chiusa di notte. Lontana e chiacchierona, maestra nelle pause, la notte penetrava nella stanza in cui dormivo e la sentivo estendersi nel mio sonno. Poggiavo il capo sopra onde che mi raggiungevano sfiorandomi con levità inafferrabile. Sentirmi come sdraiato sul fumo, su una fune, tra due nubi. La notte mi regalava una pelle. Doveva essere la pelle della notte. Ed io mi rigiravo in quella pelle immensa, che mentre mi voltavo si estendeva fino alle muschiosità primigenie.
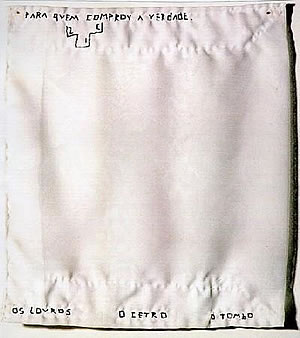 Da bambino aspettavo sempre la notte con innegabile terrore. E infatti era per me la stanza che non si apre mai, il baule dalla chiave perduta, lo specchio in cui qualcuno compare accanto a noi, una forma di tentazione. Non era la provocazione di un'avventura, né il fascino della linea dell'orizzonte. Non ci montavo sopra a cavalcioni, quando la notte si ritirava, né dovevo ricostruire, per l'altro sogno diurno, i frammenti di me che la pelle della notte aveva lasciato isolati e sparsi sul letto. Da bambino aspettavo sempre la notte con innegabile terrore. E infatti era per me la stanza che non si apre mai, il baule dalla chiave perduta, lo specchio in cui qualcuno compare accanto a noi, una forma di tentazione. Non era la provocazione di un'avventura, né il fascino della linea dell'orizzonte. Non ci montavo sopra a cavalcioni, quando la notte si ritirava, né dovevo ricostruire, per l'altro sogno diurno, i frammenti di me che la pelle della notte aveva lasciato isolati e sparsi sul letto.
La pelle immensa della notte mi lasciava innumerevoli sensazioni per innumerevoli verifiche. Il cane che di giorno mi era passato accanto tante volte senza che quasi lo notassi, ora, di notte, mi sta accanto come addormentato, e solo in quel momento lo guardo con maggior attenzione. Osservo l'incresparsi della sua pelle, il modo in cui muove la coda e le zampe per scacciare mosche inesistenti. Ringhia nel sonno e mostra i denti, rabbioso. Di notte ci sono nemici invisibili che continuano a infastidirlo. Le sue precedenti reazioni colleriche non dipendono dall'omologo delle motivazioni diurne. Non dipende, di notte, da alcuna motivazione; piuttosto, senza saperlo, sta generando innumerevoli motivazioni nella pelle della notte che mi ricopre.
La notte si è ridotta a un punto che ricomincia a crescere fino a tornare a essere la notte. La riduzione – che esperimento – è una mano. La posizione della mano dentro la notte mi dà un tempo: il tempo in cui ciò può accadere. La notte era per me il territorio in cui si poteva riconoscere la mano. Io mi dicevo, la mano non può essere li in attesa, non ha bisogno della mia verifica. E una voce debole, che doveva essere molto distante da piccoli denti di volpe, mi diceva: – Allunga la mano e vedrai che lì sta la notte, con la sua mano sconosciuta –. Sconosciuta perché non vedevo mai un corpo dietro a essa. Incerto, per paura, quindi con una decisione inspiegabile, avvicinavo lentamente la mano, come in una corsa angosciante nel deserto, fino a incontrare l'altra mano, l'altro. Io mi dicevo, non è un incubo, più lentamente, può darsi che sia un'allucinazione, ma alla fine la mia mano toccava l'altra mano. La certezza che fosse lì, faceva diminuire la mia ansia, finché la mia mano tornava alla sua solitudine. Ora, dopo quasi mezzo secolo, posso vedere chiaramente e persino distinguere i diversi momenti di quella ricerca notturna dell'altra mano. La mia mano toccava l'altra mano perché questa l'aspettava. Se la mano non ci fosse stata, la delusione, la paura, sarebbero state di certo superiori alla paura generata dal fatto che la mano c'era. Una paura nascosta dentro un'altra paura. Paura perché c'è la mano, e possibilità di paura per la sua assenza.
Seppi poi che anche nei Quaderni di Rilke c'era la mano, e poi ancora che esisteva per quasi tutti i bambini, in quasi tutti i manuali di psicologia infantile.
Lì erano già contenuti il divenire e l'archetipo, la vita e la letteratura, il fiume di Eraclito e l'unità di Parmenide. Ritrarre la mano? Ridurre la mia terribile esperienza perché già qualcun altro l'aveva vissuta? Trasformare un'esperienza decisiva e terribile in un semplice gioco verbale, in letteratura? Il tempo trascorso mi dava una solenne lezione: la convinzione che ciò che ci accade, accade a tutti. Quell'esperienza della mano che tocca l'altra mano continuerà a essere estremamente importante, anche se tutte le mani tese si incontrassero con le altre mani dell'invisibile.
Era un'esperienza talmente decisiva che, sebbene sia catalogata come psicologia infantile, ci sono ancora le notti dell'altra mano, di quella apparsa. Verrà sempre la notte in cui giunge l'altra mano, e altre notti in cui la mano resta immota, senza essere toccata.
Non aspettavo soltanto l'altra mano, ma anche l'altra parola, che sempre crea in noi un continuo fare e disfare, istante dopo istante. Un fiore che crea un altro fiore, quando su di esso si posa il cavallino del diavolo. Sapere che, da un momento all'altro, qualcosa arriva per completarli, e che dilatando la respirazione si scopre un ritmo universale. Inspirazione ed espirazione, che sono un ritmo universale. Ciò che resta occulto è ciò che ci completa e la perfezione sta nella lunghezza dell'onda. Il sapere che non ci appartiene e l'ignoranza che ci appartiene sono per me la vera saggezza.
La parola negli istanti della sua ipostasi, il corpo intero dietro una parola, una sillaba, un socchiudersi delle labbra o un'inopinata irregolarità delle sopracciglia. Il residuo di quanto di astrale vi è in ogni parola si trasformava in uno specchio momentaneo. Una sabbiolina che lasciava scritte, indicazioni. Una parola solitaria che si faceva predicativa. Il verbo era una mano dalla sudorazione eccessiva, un aggettivo era un profilo o uno sguardo diretto, occhi negli occhi, con la tensione dell'orecchio alzato del cervo.
Ogni parola era per me la presenza innumerabile della fissità della mano notturna. È l'ora del bagno, andiamo a tavola, a dormire, bussano alla porta, erano per me come iscrizioni che generavano vapori continui, appunti immutabili e ossessionanti di un romanzo. Erano larve di metafora che si svolgevano come una inarrestabile catenella, come addii seguiti da nuovi incontri.
L'attesa e l'arrivo della mano davano inizio alla catena verbale, oppure era in quell'interminabile sequenza che si incontrava la mano notturna. A volte l'attesa della mano era infruttuosa e ciò distanziava smisuratamente una sillaba dall'altra, una parola dalla sua compagna di navigazione. Era un momentaneo vuoto causato dalla lontananza, che poteva generare tanto un'attesa anelante quanto un paradossale vuoto di buon senso. Era come un lancio di dadi che si rovesciava, anzi direi precipitava su un tavolo sconosciuto. Un inquietante gioco verbale, perché qualcosa si avvicinava, in atto di sfida, e lanciava il suo richiamo, in una rete che mostrava un solo pesce ansioso di farsi amici tutti gli altri pesci.
Così trovavo in ogni parola un seme germogliato dall'unione dell'universale con l'intimo e, come alla fine dei tempi, il vuoto e il pieno di ciascun istante della respirazione saranno occupati da un'insostituibile parola unica.
In ogni parola ci sarà un seme piantato nei vasi comunicanti del discorso, ma in quel mondo il seme verbale, come nella successione dello spazio visibile e invisibile della respirazione, acquista lo stupore, connaturato nell'uomo, di una coordinata temporale. L'universo astrale, ciò che i taoisti definivano cielo silenzioso, doveva subire un processo di trasformazione nelle viscere dell'uomo, nel forno delle viscere: intime e segrete metamorfosi alle quali si deve forse l'esistenza del misterioso terzo occhio, dello specchio interiore, ormai estinto, ritrovato dai greci nell’essere, da Pascal, dagli alessandrini nell'io unificato e che in seguito avrebbe raggiunto la sua espressione più elevata nel logos spermatikos agostiniano, la partecipazione di ogni parola al verbo universale, partecipazione che racchiude in sé una respirazione, che unisce il visibile all'invisibile, digestione metamorfica e processo spermatico, che trasforma il seme in verbo universale, complementare fame protoplasmatica che genera la partecipazione di ogni parola all'infinita possibilità riconoscibile.
Ma l'uomo non si limita a germinare: sceglie. Io sottolineerei la similitudine tra questi due fatti che sono per me ugualmente misteriosi, poiché scegliendo diamo inizio a un nuovo seme che, essendo più strettamente connesso all'uomo, chiameremo atto. Nella dimensione poetica, compiere un atto e scegliere sono come un prolungamento del seme, poiché atto e scelta fanno parte della cosiddetta coscienza tattile dei ciechi, che chiamo così pur con la consapevolezza di una certa approssimazione. È un atto che si compie e una scelta che si attua a controprova nel soprannaturale. Una risposta a una domanda che non si può formulare, che ondeggia nell'infinito. Una risposta costante alla terribile domanda del demiurgo: perché piove nel deserto? Atto e scelta che si compiono nel soprannaturale. Città a cui l'uomo giunge e che poi non può ricostruire. Città edificate con una lentezza millenaria, spaccate e distrutte fino alle fondamenta in un batter di ciglia.
Fatte e disfatte con il ritmo della respirazione. A volte abbattute da un'improvvisa caduta celeste, altre volte erette come l'istantaneo colonnato di un movimento tellurico.
Cos'è il soprannaturale ? La penetrazione dell'immagine nella natura genera il soprannaturale. In questo ambito non mi stanco di ripetere la frase di Pascal che fu per me una rivelazione: “Giacché la vera natura si è perduta, tutto può essere natura”; la terribile forza assertiva di questa frase mi spinse a collocare l'immagine al posto della natura perduta, cosi, dinnanzi al determinismo della natura, l'uomo risponde con il completo arbitrio dell'immagine. E dinnanzi al pessimismo della natura perduta, l'invincibile allegria nell'uomo dell'immagine ricostruita.
Dimorano nelle rovine? Sono comici in vacanza? C'è un pittore, qui? Osserviamo il quadro di Goya, La grotta, una delle sue tele migliori e meno note. Sullo sfondo, il cielo viola e le nubi accavallate di El Greco, contrastano con il volo tranquillo delle colombe. Coperte dalla tovaglia, o sotto il tavolo, si nascondono per far sì che le colombe si avvicinino. È un colosseo in rovina, una piazza disabitata, l'ala distrutta di un convento. Dinnanzi a questa desolazione hanno imbandito una tavola, e un'apparizione coperta da una tovaglia beccata dalle colombe produce attesa e grazia. È uno spazio sconosciuto, un tempo errante che non alberga sulla terra. Tuttavia camminiamo nel qui e viviamo nell'ora, e riusciamo a ricostruire un'immagine. È il soprannaturale.
Il soprannaturale non si manifesta solo nell'intervento dell'uomo sulla natura: sia l'uomo sia la natura, ciascuno a proprio rischio, concorrono al soprannaturale. Tra i tartari, i bambini morti si sposano. Su carte sottili si disegnano i guerrieri che assistono alle nozze, gli orchestrali, i famigliari che portano le coppe delle libagioni. I presenti firmano e le firme si conservano in archivi ben protetti. I genitori dei bambini morti cercano di stare uniti, vivendo in case vicine. Mettono in comune i loro beni e osservano i festeggiamenti rituali. La vita ribolle intorno ai morti e la coppia di bimbi morti penetra nella vita. È la replica all'affermazione dei morfologi di scuola goethiana, secondo la quale ogni specie, perfezionandosi, genera una nuova specie; allo stesso modo, la natura, accresciuta dall'immagine apportata dall'uomo, giunge al nuovo regno del soprannaturale.
Nelle mastabe egizie, una porta restava aperta per ricevere il vento magnetico del deserto. Venti genetici che continuano ad accogliere i morti. La penetrazione piramidale verso il Nord, nella terra bruciata, faceva sì che la camera mortuaria della regina fosse costruita secondo l'orientamento più favorevole a ricevere il vento magnetico nel deserto della genesi. Perciò credo che la costruzione delle piramidi non perseguisse soltanto il fine di fornire il più duraturo edificio mortuario, bensì la camera genetica dei re, dove procreare sfruttando il vento del deserto. Si raggiungeva così la vera successione dai re morti ai re viventi. Una dietro l'altra si susseguivano le piramidi, allontanandosi sulla terra bruciata, verso la regione dei morti. Come l'humus, la terra fangosa, era abitata dai vivi, così, proprio sul confine della morte, la camera della genesi della regina riceveva la pienezza del vento magnetico, al quale sono tanto sensibili i fantasmi elastici di Baudelaire e i gatti, divinizzati dalla cultura egizia.
Per gli egizi, l'unico animale dotato di parola era il gatto, diceva un come che univa le punte magnetiche dei suoi baffi. Quei due punti magnetici, infinitamente relazionabili, sono alla base dell'analogo metaforico. E un relazionabile genetico, copulativo. Si uniscano i punti magnetici del riccio con quelli della bisaccia e, con un esempio che ci è caro, nasce la castagna. Il come magnetico risveglia anche la nuova specie e il regno del soprannaturale.
Il soprannaturale non ha molto a che vedere con il proton pseudos, la menzogna poetica dei greci, poiché il soprannaturale non perde mai la primordialità da cui procede: assomma l'uno con l'uno che non ha doppio, dato che l'uomo è immagine, partecipa come tale e alla fine si ritrova con il completo chiarimento dell'immagine; se gli venisse negata l'immagine, non potrebbe conoscere la resurrezione. L'immagine è il complemento continuo di ciò che è intravisto, parzialmente udito, il temibile entredeux pascaliano si può colmare solo con l'immagine.
L'horror vacui è la paura di restare senza immagini, nelle epoche in cui sulla frantumazione spiroidale del demiurgo predominava la compiutezza combinatoria e pessimista dei corpuscoli. In molte leggende medioevali è presente lo specchio che non restituisce l'immagine del corpo se questa è deforme o demoniaca: quando lo specchio non parla il demonio mostra la sua lingua saburrale. Quella convinzione innata nell'uomo secondo la quale la chiave che apre una casa ne apre anche un'altra, la spada che guida un esercito ne guida un altro nel deserto, un mazzo di carte apre un altro gioco in un'altra regione. Dovunque, la reminiscenza di un incondizionato che ignoriamo, generata da un causalismo del mondo visibile, viene avvertita come la città perduta che riconosciamo. In realtà, ogni sostegno dell'immagine è un'ipertelia, supera il proprio scopo, lo ignora e offre la sorpresa infinita di ciò che ho chiamato l'estasi di partecipazione all'omogeneo, un punto errante e, per estensione, un'immagine. È un albero, una reminiscenza, una conversazione che segue il tracciato del fiume con l'indice.
Seme, atto e quindi potenza. Possibilità dell'atto, l'atto su un punto e un punto che resiste. Quel punto è un Argo, una lince, e solca lo spazio. Le sue orme, come fossero dotate di una fosforescenza invisibile, permangono. In tutto questo vi è una possibilità finita che la potenza interpreta e svolge. L'atto dell'uomo può riprodurre il seme nella natura e rendere la poesia permanente per la segreta relazione tra seme e atto. E un seme-atto che l'uomo può ottenere e riprodurre. L'unità ululante e penetrante di una partita di caccia, un grido d'esaltazione, la risposta dell'orchestra che permane nel tempo, i guerrieri all'ombra delle mura d'Ilio, la grande armée, ciò che ho chiamato Le ere immaginarie e anche il soprannaturale formano, per un intreccio del seme, atto e potenza, nuovi semi sconosciuti, atti e potenze. Poiché seminare nella terra è come farlo nello spazio, e seguire il corso di un fiume è come camminare scostando le nubi allo stesso modo in cui nel teatro cinese un movimento delle gambe significa montare a cavallo.
La potenza, quando si applica in un punto o quando agisce in uno spazio, è sempre accompagnata dall'imago, l'unità più profonda che si conosca tra cielo e terra. Se la potenza agisse senza l'immagine, compirebbe soltanto un atto autodistruttivo e privo di partecipazione, mentre ogni atto, ogni potenza è una crescita infinita, smisurata, in cui il cielo sostiene la terra. L'immagine, partecipando all'atto, ci consegna una specie di visibilità momentanea che, senza di essa, senza l'immagine, unico mezzo a disposizione dell'uomo, sarebbe un'impenetrabile dismisura. In questo modo l'uomo si impadronisce della dismisura, la fa emergere e vi incorpora una nuova dismisura. Ogni poiesis è un atto di partecipazione a quell'eccesso, una partecipazione dell'uomo allo spirito universale, allo spirito santo, alla madre universale.
L'uomo in quanto seme evidenzia questo sviluppo nella sua circostanza, un tronco dall'ampia base lo rende simile al fervore per una fondazione, sebbene non sapremo mai, partendo dalla natura, quali serie causali producano lo splendore o la putredine, né in che momento l'incondizionato irrompa irrefrenabile nelle serie causali. In alcune città dell'Asia, in occasione del passaggio dalla vita alla morte, non si fa uscire il morto dalla porta, bensì si abbatte un muro della casa, quasi a prepararlo per una nuova causalità. In altre città asiatiche, durante la cremazione si bruciano anche fogli disegnati dagli amici, gioielli e cibi, per offrire inseparabile protezione e compagnia durante il viaggio che si suppone avvenga in una nuova dimensione.
In pochi casi di scelta, è l'espressione usata nella Bibbia, il suo sviluppo nella vita procede quasi di pari passo a una prodigiosa anticipazione della nuova dimensione. Dallo sterile terreno castigliano nascono le fondamenta del pensiero teresiano, come una casa obliqua, che si riproducono in Martí, introducendo, al posto della sterilità, il seme paradossale dell'esilio. Dopo la prigionia, Martí dovette provare una specie di rinascita nell'immagine della resurrezione, come dopo la morte risorge la carne. La sterilità e la sua nuova apparizione simbolica nell'esilio si eguagliano, e perciò nel Paradiso, per propiziare l'ultimo incontro tra José Gemi e Oppiano Licario, per giungere alla nuova causalità, alla città tibetana, si devono attraversare tutti i corsi e i ricorsi della notte. La discesa uterina della notte, il fiele della mezzanotte, sono varianti del deserto sterile e dell'esilio, ogni possibilità del sistema poetico è stata messa in moto affinché Gemi non manchi all'appuntamento con Licario, l'Icaro, il novello esploratore dell'impossibile.
Paradiso, mondo fuori dal tempo, è pari al soprannaturale, poiché il tempo è anche la natura perduta e l'immagine si ricostruisce come soprannaturale. La liberazione del tempo è la costante più tenace del soprannaturale. Oppiano Licario vuole provocare il soprannaturale. Prosegue così la sua ricerca attraverso continui labirinti. Capitolo XII negazione del tempo, dietro l'urna di cristallo si scambiano continuamente volto il giovinetto e il centurione morto, e solo nel capitolo XIV, ormai alla fine, dietro l'urna, appare Oppiano Licario stesso. Negazione del tempo ottenuta nel sogno, in cui non solo il tempo ma anche lo spazio scompare. Smuovo l'enormità di un'ascia, raggiungo velocità infinite, vedo ciechi in mercati notturni conversare sulle qualità plastiche delle fragole, gioco a Tabatra le rovine, ottengo la tetractis, il quattro, dio. Il capitolo XIII cerca di illustrare un perpetuum mobile, per liberarsi dal condizionamento spaziale. La testa del montone, girando su un pignone conquista tale liberazione; nella dimensione di Oppiano Licario, quella, del soprannaturale, le figure dell'infanzia ricompaiono. È l'infinità della conoscenza acquisita attraverso Licario, solo che il ritmo dei pitagorici è diverso: dal ritmo sistolico, quello violento delle passioni, si è passati al ritmo esicastico, alla calma, alla saggia contemplazione.
Licario ha messo in moto le immense coordinate del sistema poetico per propiziare l'estremo incontro con Cani.
Era necessario che Gemi salutasse questo incontro con le parole di Licario. L'immagine e il ragno nel corpo, dice una di quelle frasi pronunciate durante l'ultima notte. Appare la sorella Inaca Eco Licario a consegnare la frase poetica come la terra promessa. L'ombra, il doppio, è ciò che fa l'offerta. Il doppio fa la prima offerta, restituisce la prima immagine e Gemi ascende, attraverso la pietra sacrificale, a onorare il proprio patronimico di idolo o immagine. Supponiamo una pitagorica notte celeste del 1955. Ho trascorso diverse ore ad ascoltare L'arte della fuga di Johann Sebastian, assorto nell'intreccio della fuga per canone. Infinite relazioni emergono dagli spiraloidi del notturno. Le costruzioni e le dilatazioni del ritmo si ripetono in ogni nostro passo e cresciamo camminando. Infiliamo una di quelle vie dilatate come fiumi paradisiaci. Le luci notturne delle pompe funebri devono fermare il passante senza che se ne accorga, facendolo sussultare. La musichetta ripetitiva di una giostrina sostiene e affretta l'andatura di una passeggiata notturna. La casa, nella sua dimensione verticale, come un albero impazzito, ci lancia la tentazione della sua terrazza più alta, dove protetti dal priapico dio Termine, due buffoni giocano a scacchi. E come la ripetizione di una marcia circolare. Sul limite stesso della morte le coordinate del sistema poetico agitano disperate le braccia, esaurita la natura sussiste il soprannaturale, rotta l'immagine tellurica cominciano le incessanti immagini astrali. Là, nella più intoccabile lontananza, dove i pitagorici posero un'anima alle stelle.
È una sorpresa, la casa accecante di luci, che l'uomo interpreta addensando la saliva, nella coniugazione della circolazione linfatica con quella sanguigna. Un maestoso e un vivace formano una nuova unità che penetra nell'invisibile come un pezzo degli scacchi. Anche nella giostra c'è una ripetizione circolare che si rompe in spirali, in una pioggia di stelle nella notte babilonese, nella cometa che precede e annuncia la morte di Giulio Cesare. Un gatto nero di grossa taglia, che va da una folla all'altra annunciando la morte. I globi arancioni che esplorano la notte di Van Gogh, lanciati come pietre nel ventre della balena. E la conversazione segreta alle porte di Toledo in El Greco. E la musichetta ripetuta all'infinito della giostra, fra la casa accesa dalla morte e l'infinito poliedro verticale in cui l'immagine vorrebbe stabilire la propria residenza invernale. È l'ansia indomabile di arrivare alla città tibetana celeste, dove l'uomo conversa con il bufalo bianco, dove l'ombra della vegetazione penetra nel sonno. Un giorno udii uno dei nostri poeti di decasillabi dire, mentre risaliva un ottosillabo: “L'anima si rende nell'ombra”. Intuizione coincidente con quella del teologo che ci ammonisce che l'uomo deve sentire come le piante, pensare come gli angeli e vivere come gli animali. Forse all'altro capo della fune dell'angelo non c'è la bestia, bensì quella felice coincidenza dell'otium cum dignitate dell'umanesimo, e nel pascolo delle bestie entrambi, manifestazioni della contemplazione del cielo silenzioso dei taoisti. Il giorno in cui potremo distinguere chiaramente l'otium dal pascolo, la vera natura sarà abitata di nuovo, poiché in entrambi coesiste l'attesa del celestiale, il mondo dell'infinita apertura, l'esatta relazione tra l'animale e il suo ambiente, infatti, non è stata ancora approfondita e ignoriamo il modo in cui si stabiliscano le interrelazioni del verbo universale, ma un giorno il mondo della nosis e il mondo della physis saranno univoci. Una sorpresa nel corso delle stagioni. Piogge, piogge. Il filo freddo, quando ci corichiamo, sulle prime sembra respingerci, dobbiamo premere più forte il cuscino contro la guancia per saggiare la dolcezza dell'appoggio, come se navigassimo opponendo la prua a una resistenza che si può vincere. Il sonno, prolungandosi, occupa nuovi frammenti notturni. La lana notturna, con cauta lentezza, s'impossessa del filo diurno, il capro continua a ballare, ma ormai fuori dal raggio di sole. L'occulto, ciò che è chiuso sotto chiave e blindato, apre le sue porte e offre la nuova e silenziosa sontuosità di un nuovo mercato. Le monete di cotone che non tintinnano, acquistano tele magiche. I fagotti, conservati in magazzino, vanno verso i quattro falò che splendono ai quattro angoli del mercato, e ora sono un grappolo di volti. L'occulto, l'oscuro, prende forma quando giunge la nuova stagione, è il bambino che ogni mattina esce di casa nella poesia di Whitman. E torna e comincia il suo racconto. Si perde e continua il racconto. Lo sentite?
Nella grande casa della Caserma io vedevo giungere l'inverno. La cucina, la sala da pranzo e le camere assumevano differenze più sottili, il loro silenzio risuonava più verso l'interno, la conversazione si faceva più sommessa. La nonna ci faceva visita più di frequente. I preparativi per la visita erano molto lunghi e accurati, sembrava che dovesse restare da noi tutto l'inverno, ma ecco che il giorno seguente, a colazione, già la sentivamo dire: “Non mi piace abbandonare la casa di Prado”, usando la parola con cui una regina fa riferimento a un castello abbandonato, o con cui ci riferiamo ai figli della vicina di casa, abbandonati a se stessi. Abbandono e incuria erano intollerabili per la nonna. Trascorreva la giornata in allegria, ma la sera cominciava già a prepararsi per il ritorno. Io trascorrevo il resto del giorno nella tristezza di quell'addio. Attraversavo con lentezza eccessiva tutte le stanze di casa. Camminavo adagio dalla sala al cortile e lí vedevo stesi i copriletto che inauguravano l'inverno. Qualcuno si avvicinava e con lunghi rami cominciava a battere i panni. La polvere battuta si trasformava in uno scintillio che ingrandiva o faceva scomparire i volti che spuntavano dietro i panni, finché i rami non li cancellavano del tutto. Mi piaceva, nelle nebbiose giornate invernali, contemplare quei volti che erano solo proiezioni della mia imago e che poi sparivano, come in uno starnuto causato dalla polvere.
Ho cercato di fissare in una poesia quei volti:
Colpiva il pastore con il suo bastone, le tele più fini,
dopo l'inutile rumore del turbamento,
un altro richiamo, già svanito, ci giunge.
Quel rumore, nascendo da un'altra porta,
si dissolve nelle domande di una morte.
Rumore d'altro infine si perderebbe,
se non fosse universale la carne della tela.
Nuotando nel nostro istante qualcuno viene a offrire il suo collo per delizia o successione,
e sebbene il bastone si plachi lungo le vene,
fa uscire, uscire i volti dalla tela.
Il colpo non è quello destinato a ogni volto
e ogni volto si perde nella tela.
Ma la poesia era dettata dalla temerarietà, il suo titolo dall'esoterismo pitagorico e dalla matematica simbolica era percorso da un'altra ingenuità adolescente. Era accompagnata, la poesia, da un altro ricordo, e non erano le nubi dell'autunno, bensí le operazioni algebriche. Ciò che si nasconde dietro la luna piena dello zero. Una quantità negativa veniva a sostenere un'altra crescita nel ricordo. Sorgono dai panni invernali, dietro le nubi polverose, angioletti paffuti o ossute teste ciondolanti, che trasudano pece e catrame. Ricordate che le figure sorte da scintillii, da mulinelli di polvere o da nubi, portano visibili residui di catrame sui denti, sulla punta delle dita, sui lobi delle orecchie ? Sono forse i segni di un'eredità o di un'origine ? Sconosciute filiazioni del mondo di carbone e delle folgorazioni, si tradiscono a volte, e questo li rende riconoscibili, per le spine o il pulviscolo, residui delle loro conversazioni con Maria la luna.
Nascosti sotto lo zero, negli strati polverosi, i volti continuavano a fuggire. Quando i rami cominciarono a battere i panni, i segni graffiavano le quantità negative per cercare di trattenere qualche volto, qualche linea incrociata, finché poi il panno risultava animato da conversazioni, dopocena, volti intercambiabili. Pareva che le maschere fossero conservate in vetrine a tre ante e che riapparissero da una stagione all'altra.
La casa non offriva soltanto questa attesa metamorfosi, ma anche una continua meraviglia occulta. Lo studio del colonnello. Tavoli con mappe e disegni, panoplie, diplomi, medaglie, sfere armillari, proiezioni di Mercatore. Si trovava oltre la camera da letto dei miei genitori, limite che noi non superavamo mai. Questo aldilà era lo studio dove il colonnello trascorreva gran parte delle serate e delle notti. Se capitava che entrassimo in quella stanza, da qualche porta aperta furtivamente, ne fuggivamo correndo, spaventati, come chi entri in un'atmosfera refrattaria. Entravamo lentamente, guardando un angolo, un'ombra, un mobile che gemeva e ne uscivamo di corsa, come frecce scagliate.
Era anche un regalo del corso delle stagioni. Si apriva alla curiosità degli altri abitanti della casa nel felpato transito da un'estate a un inverno. Lì si potevano ammirare un pezzo di marmo verde e nero, disegni comparativi di daghe fiorentine e berlinesi, una scacchiera di ossidiana dai pezzi grandi quanto una mano. Si apriva semplicemente per arieggiarla, ma per noi era una specie di scongiuro, una sfida, qualcosa che invitava a un atto eccezionale e a una fuga dissimulata. Queste apparizioni a ogni cambio di stagione, questi fugaci avvenimenti che stanno oltre i limiti della conoscenza, si verificavano con lentezza, con quella specie di riparata indolenza propria della ripetizione. L'insistenza non pareva appartenere alla loro natura. Erano scorci fugaci, nell'ombra, ma poiché ci colmavano, oggi, che da essi ci separa la polvere sabbiosa del tempo, pare quasi che si ripetessero a sazietà, come se innumerevoli volti continuassero a uscire dai panni battuti, come se avessimo trascorso vere stagioni al di là delle Colonne d'Ercole.
Da quella stanza, ripostiglio, biblioteca, riposo dell'errante, si andava dipanando la magia che ho sempre percepito in ogni dimora dell'uomo, come il guscio di una chiocciola che offre i suoi labirinti difensivi all'ondata della marea notturna.
Era la convinzione che lì, nella lontananza dell'immediato, convergevano tutte le scintille di una fucina invisibile. Tutte le case erano addormentate, ma in quel luogo, che non era uguale agli altri, avvertivamo quella disuguaglianza fin nei nostri più intimi e tortuosi sentieri, si compivano movimenti di millenaria lentezza, oppure originati da una ruota che gira vertiginosamente. Lì la vita assumeva movimenti indecifrabili, resti di una liturgia in un bosco disabitato o dense infiltrazioni in una grotta sottomarina, ma i dormienti arrivavano con le loro piccole conchiglie per l'audizione stellare e ampi leggii consentivano di intonare le salmodie.
La convinzione che il drago, ciò che c'è e non c'è, compare e scompare, necessita di un rifugio oltre le Colonne d'Ercole, ha nella biblioteca il suo spazio soprannaturale. Là si cercava una compagnia per la solitudine, e più specificamente nella biblioteca pubblica, dove la compagnia cerca una solitudine. La lotta contro il drago doveva consumarsi nell'eterna relazione tra solitudine e compagnia. Dal ricordo della stanza misteriosa, oltre le Colonne, nella Caserma, sarebbe nata la mia idea della cultura cinese; la biblioteca come drago. Lao Tze, quello del senso dell'increato creatore, fu un bibliotecario e il Dott. Kungste, il Confucio dei gesuiti, spese gli ultimi quattordici anni della sua vita sui Ching, il Libro dei Mutamenti, del visibile e dell'invisibile, in cui il drago dimora per parlare con i morti e tracciare le coordinate tra l'insignificante e la dismisura stellare. E così come si può ravvivare con il fuoco il leggibile, si può parlare con l'invisibile.
Il solo affannoso tentativo di contenere in un libro l'inudibile, l'invisibile, di far si che l'increato creatore abbia un senso, ci dice che il duello con il drago deve avvenire oltre le Colonne, che avverrà in un'era immaginaria, che dimorerà nel soprannaturale. Come al demonio di certe leggende medioevali piace dormire all'ombra del campanile, così al creatore increato piace trascorrere la giornata nella biblioteca, perché la biblioteca viene a essere un inudibile, un invisibile e così la natura tornerà a incontrarsi nel soprannaturale.
Abbiamo anche perduto il senso esistenziale di quella cosa tanto importante per l'uomo quanto il focolare, il bicchier d'acqua, lo specchio e la spada, che è l'alfabeto, l'avamposto perché le carovane non si perdano nel deserto. Con il ricordo della casa, del fiume, delle piantagioni, del toro, nell'alfabeto incontriamo le cinque lettere introdotte dalla poesia. Sono segni indecifrabili, non devono essere segni di reminiscenze di figure, come simboli del perdurare della sfida segreta custodita nell'alfabeto. E l'offerta della poesia, cinque lettere sconosciute, errante analogo dell'astrale con il tellurico, della nube che entra nello specchio. Erano le lettere che stanno sul fondo e saltano come pesci quando beviamo l'acqua nel cavo della mano. Mi affacciavo di nuovo sul cortile e anche quella distanza tra il limite della casa e la linea dell'orizzonte si popolava di sconosciuti. La presenza della mano sopra la mano, alla mezzanotte, si trasformava nella fila di muli che entrano nel bosco, nell'oscurità. Li osservavo e li vedevo entrare in un destino che ignoravano con la più invincibile resistenza. Attraversavano la caduta e la redenzione, sopportando una totale pena. Più mi avvicinavo e più vedevo nitido il tremito della loro pelle. Sudavano, tremavano ed entravano. Ignoravano il loro destino ma resistevano. Entrano nella loro caduta, come nella gloria, e la loro resistenza illumina il passaggio dei grandi trasporti. Si direbbe che al castigo che ricevono offrano il castigo della loro resistenza. Senza saperlo superano le Colonne, respirano come un mantice nel soprannaturale e trasportano le ampie fondamenta delle ere immaginarie. Le loro distanze sono occupate dalle costanti trasformazioni della poesia. La resistenza del mulo getta il seme nell'abisso, come la durata poetica semina e risorge nell'universo. L'una resiste nel corpo, l'altra resiste nel tempo, e di entrambe si vede la pinna che cerca il complemento sconosciuto, conosciuto, sconosciuto.
Con il desueto aumento delle collezioni di ritratti, sentivo che passavo dallo zenit ardente, dalla maniera dello splendor formae, al buio sommerso. Alla morte di mia madre, il suo quaderno di ritratti andò ad aumentare la mia collezione; nella sua predominavano i trapassati all'oscuro Ade, e nella mia i miei contemporanei, felici seppure nella regione della luce. Ciò che ora posso contemplare con apparente serenità, fu per me uno scontro violentissimo e senza rimedio. Era come se le antiche relazioni, i più patetici racconti familiari, si popolassero di nuovo, si raccogliessero nel dopocena e potessero dialogare tranquillamente con noi, senza la minima sorpresa da parte nostra.
Tra tante vertiginose prove, io mi trovavo come sommerso nell'oscurità. Le fotografie, mentre si allontanavano sempre più verso i confini del passato, assumevano per me lo splendore smorzato di una lettura al lume di una lampada a petrolio. Quei ritratti ritrovavano la loro allegria serena, la loro serica compagnia. Erano apparizioni reali, esistenti tangibili nell'immagine, che prestava loro un corpo in grado di muoversi, una voce udibile e un addio spaventato. L'immagine che avevano abbandonato come un uovo, ridava loro corpo. Abitavano il palazzo dalle finestre verdi, passavano per la città delle cento porte, assistevano alla messa nella Cattedrale dell'Avana. Quella gente squisita, delicatissima, che non si lamentava né si affrettava mai, non aveva bisogno di me per raggiungere la casa in cui dimora il drago. Sono io lo spirito intontito da quegli emigranti apparentemente confusi, colui che ascolta, insegue e somma di nuovo il cotone e il profumo della vaniglia, la lampada oscillante e il giallo ancestrale dei pizzi. Ecco Andresito, il bimbo prodigio, col suo violino, morto in un incidente durante una tombola per raccogliere fondi per l'Indipendenza. Quella sera suonava con lo smoking che usava spesso suo padre. Cade dal montacarichi e muore, e mio nonno che muore di dolore di lì a poco. E mia nonna, che quando raccontava quell'episodio concludeva sempre con una specie di antistrofe di una qualche tragedia greca: perché proprio mio figlio ? Da bambino volevo fare il violinista, colui che sarebbe riuscito a esprimersi al posto di affrontare il fatum. Si delineava in me costantemente, ancor più attraverso la morte. Era l'assente, con la parte migliore della famiglia nella tenebrosa Moira, occupava tutto il sympathos familiare e mi dilettavo ad ascoltare mia nonna e mia madre raccontare com’erano state le sue ore di studio e la notte della sua morte. E la delicatezza della zia Queta, la sorella di mio padre, segretamente innamorata dello zio Alberto, il fratello di mia madre, che sotto l'apparenza dello zio indiavolato di tutte le famiglie, custodiva come un tesoro uno stile di conversazione che ho sempre cercato di far rivivere alle origini dei miei racconti.
Nel 1880, mio nonno materno, un vero cubano, rivoluzionario, e per questo emigrato anni più tardi, fa un viaggio in Spagna. In quegli stessi anni, mio nonno paterno, basco, un vero spagnolo, fa un viaggio a Cuba; anni dopo entrambe le famiglie intrecciano i loro destini in modo tale che quando mi sono sentito chiamare basco creolo ho provato un sentimento di orgoglio peculiare; ma il mio vero orgoglio non lo devo neppure confessare.
Pochi anni prima della sua morte, mia nonna apri un armadio titanico che si trovava nell'ultima stanza della sua casa di Prado, dove la giovinezza senti come su di me si andava inclinando l'alluvione della reminiscenza. Lì vi erano lo smoking di mio nonno, con il quale era morto mio zio Andresito, e i vestiti con i quali mia nonna aveva assistito alle nozze delle figlie. Vi erano anche uno smisurato scrittoio con calamaio per l'inchiostro e delle renne in argento lavorato e, sulla scrivania, una manina d'ambra molto usata nei secoli XVIII e XIX per grattarsi. Quell'ingenua ondata reminiscente passa alla seconda strofa della mia Ode a Julián del Casal, quando per suggerire il titolo di una delle sue opere alludo a una delle renne dello scrittoio e a una manina d'ambra per la schiena. A volte penso, con delizia, che nel giorno degli addii quella vetrina gigantesca si riaprirà per me. Riascoltiamo:
Lasciate che ci accompagni senza parlare,
permettetegli, dolcemente, che si giri
verso la fruttiera in cui stanno gli orsi
con il piatto di neve, o la renna
della scrivania, con la sua manina d'ambra.
Era una richiesta che facevo per Casal e per me.
Nell'armadio magico, il violino di zio Andresito, al riparo dalla polvere nella sua custodia ben chiusa, mostrava venature silenziose nel legno. Striature d'ambra, piccolo tumulo di diaspro, minuscola e graziosa cittadella edificata da Anfione. Nelle sfilate dei miei Trattati all'Avana, in cui non voglio scegliere un paio di scarpe in una vetrina, in cui affermo che il segno nella tiorba non si decifra, in cui congetturo che il primo flauto sia stato ricavato da un ramo rubato, appare a un tratto il violino di ghiaccio avvolto nel sudario della reminiscenza, che risveglia la bella addormentata nel bosco, che nella reminiscenza fa e disfa la treccia. E il violino che pare esalare l'orchestrazione finale: la mia anima non sta dentro un posacenere.
Un'antica leggenda indiana ci ricorda l'esistenza di un fiume di cui non si riesce a individuare la confluenza. Alla foce il suo corso forma un cerchio e ribolle la sorgente. Una confusione smisurata, si osserva nella sua portata: dissomiglianze, appiattimenti, concorrono con adamantine simmetrie e coincidenti tenerezze. E il Purana, che tutto travolge, appare sempre confuso, è privo dell'analogo e di approssimazioni. Eppure è il fiume che giunge alle porte del Paradiso. Nei riflessi delle sue onde sfilano il vestibolo del guardiano del faro, l'albero di corallo, la catena dell'occhio di tigre, il Gange celeste, la terrazza di malachite, l'inferno delle lance e il riposo del perfetto. La costante contemplazione del fiume consegna il suo dualismo, l'avventura dell'analogo e le coppie che si ritirano sulle isolette. Un albero dinnanzi ad alcuni occhi, un albero di corallo davanti all'occhio di tigre; le lance davanti alla terrazza, e poi le lance infernali davanti alla paradisiaca terrazza di malachite. Beati noi effimeri, che possiamo contemplare il movimento come immagine dell'eternità e seguire assorti la parabola della freccia fino al punto in cui si conficca nella linea dell'orizzonte.
José Lezama Lima (L’Avana 1910 – 1976), poeta, romanziere e saggista cubano. Ha precedenetmente pubblicato in Italia il romanzo Paradiso.
(Tratto dalla raccolta Racconti, [Appendice], Einaudi, Torino, 2004)

 Precedente
Precedente  Copertina
Copertina
|