|
 ISTITUTO D'ARTE
ISTITUTO D'ARTE
- Brano tratto dal romanzo Nati due volte -
Giuseppe Pontiggia
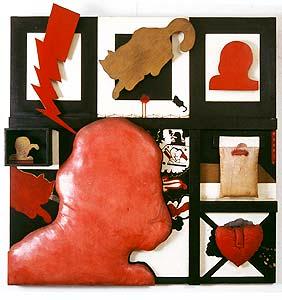
Ho insegnato per anni in un Istituto d'Arte. Vi ero entrato (seconda nomina) quando ne avevo ventotto. Non avevo mai conosciuto un disabile. Oggi ne vedo molti, non so se perché l'occhio si è affinato o il numero è aumentato. Credo tutte e due le cose.
In una classe avevo una alunna bionda al primo banco. I capelli fluenti sulle spalle larghe, il viso rotondo, mi sembrava una nuotatrice australiana appena uscita dalla piscina e rivestita dopo un allenamento. Il corpo esprimeva scioltezza e forza. Serena, intensamente inespressiva, gli occhi luminosi, seguiva la lezione con una attenzione ipnotica.
La prima volta che la interrogo a lato della cattedra, le mani dietro la schiena, statuaria e composta, non capisco quello che mi risponde.
«Puoi alzare la voce?» le chiedo.
Butta indietro la testa, stringendo le labbra, e mi fa cenno di no, come se le chiedessi qualcosa di impossibile.
La guardo stupito e allora lei si volta verso la classe, quasi a domandare aiuto. Qualcuno qua e là, tra i banchi, sorride. Lei si gira di nuovo verso di me, bisbiglia parole incomprensibili.
Io allungo il collo nella sua direzione e le faccio segno di parlarmi all'orecchio. Piego con la mano sinistra il padiglione, formando l'incavo a conchiglia tipico dei sordi (lascio "non udenti" a chi non ha familiarità con l'handicap). E lei si curva verso di me, rossa in viso, sussurrandomi con una voce fioca:
«Mi scusi, non riesco a parlare più forte.»
«Non si preoccupi» le rispondo con aria spavalda. «Si fa capire benissimo.»
Ho pochi anni più di lei e mi sento disponibile, generoso, corretto, liberale. Un giovane insegnante magnifico, all'altezza del compito. La classe ridacchia, alcuni si sottraggono al controllo curvandosi dietro le spalle del compagno, altri si toccano con i gomiti, altri vorrebbero frenare un riso convulso e trasformano il rictus in un nitrito silenzioso.
Chiedo alla ragazza risposte brevissime: titoli, date, luoghi, nomi, nozionismo puro (del resto non spregevole, come si capirà quando lo si sarà abrogato). E lei fa brillantemente la sua parte, sorpresa dalla mia metamorfosi nell'interrogare.
La congedo con un largo sorriso e un lieve sudore sulla fronte. È preparata, le do un voto alto, scrivendolo sul registro con una gestualità trasparente. Sono un piccolo eroe della didattica moderna, funzionale e disinvolta. Anche la classe sembra apprezzare, qualcuno è passato dal riso al sorriso, che non è una acquisizione da poco.
La sua compagna di banco, mentre lei si siede al suo fianco, stanca e felice, mi informa che questi problemi sono minori con gli insegnanti delle materie tecniche, dove si parla meno. Solo con il professor Cornali, di storia dell'arte, le difficoltà si ingigantiscono. Me lo comunica con una franchezza spigliata, facendosi sentire dalla compagna, che annuisce, e dalla classe, che si riconosce nelle sue parole. È la mia delatrice ufficiale, a metà tra il rappresentante sindacale e il legato dell'esercito.
«Perché con il professor Cornali ha problemi?» le chiedo. La ragazza sorride maliziosa:
«Perché lui dice che è sordo.»
La classe rumoreggia moderatamente, offrendo la conferma di un coro scettico.
La ragazza aggiunge:
«Invece sente benissimo. Fa così per metterla in difficoltà.»
La verità probabilmente sta in mezzo. Il professor Cornali è forse un po' duro d'orecchio e la ragazza gli crea qualche problema, fraternamente ricambiato.
«Verificherò» commento.
Ho verificato. Ma in mezzo sta la virtù, dice Orazio, non la verità. Altrimenti sarebbe risolto il problema. La verità, per quanto riguarda gli uomini, è sempre diversa.
Cornali non ha disturbi di udito. Ha invece disturbi nei rapporti con gli studenti. In questo non si distinguerebbe da nessuno di noi. Chi potrebbe negarlo? È vero, c'è qualcuno che lo nega. Ma appartiene a quella classe di idioti euforici che dichiarano alla televisione: «Ho avuto tutto dalla vita». Che sarebbero sopportabili se non fossero invece arroganti, sperando di suscitare, anche nell'epilogo, l'invidia per una vita immaginaria.
Cornali ha però disturbi particolari con chi soffre di disturbi. È un tratto che ho messo a punto più tardi, osservando le reazioni che i disabili suscitano in una specie ignorata di disabili, quelli normali. Il simile si cura con il simile, è il principio che Hahnemann, nell'Ottocento, pone a fondamento della medicina omeopatica. Il debole si cura con il debole, è il principio che ho visto applicato nella pratica dei rapporti umani in occasioni molteplici, tra edificanti e sinistre. Se un bambino disabile viene immesso inaspettatamente in un gruppo di bambini, tutti lo guarderanno dapprima con curiosità o stupore o sgomento, secondo l'inesorabilità dei punti di vista. Gli unici che conserveranno una attenzione concentrata, una partecipazione ambigua e un occhio torbido saranno quelli che cercano in lui uno specchio. Alcuni, avvinti quanto sopraffatti dalla paura di riconoscersi, reagiranno addirittura con la fuga o l'aggressività. Ma tornare è il loro destino vischioso, la loro sconfitta rassicurante. Che la nevrosi attragga, intensifichi e soddisfi un'altra nevrosi è del resto confermato dalla durata di molti matrimoni.
Cornali ha preso subito di mira la ragazza. Ha finto di compiere ogni sforzo per riuscire a sentirla - così mi ha raccontato la delatrice durante l'intervallo, nel vano della finestra in corridoio, tra gli sguardi fuggevoli e ammiccanti delle compagne di passaggio - e ha chiesto minuziosi ragguagli sulle cause del suo disturbo, contribuendo ad accentuarlo. Ogni volta mostrava di capire troppo poco ciò che lei gli diceva, curva sulla cattedra, a distanza ravvicinata. No, lui non si faceva parlare vicino all'orecchio, anzi, una volta che lei si era accostata, l'aveva allontanata con un gesto violento. Lei era scoppiata in lacrime.
Scopro ciò che avrei dovuto immaginare. Ogni insegnante ha un problema diverso con la ragazza, secondo la diversa materia. Ma ognuno riesce ad aggirare l'ostacolo. Questo attenua l'orgoglio per la mia versatilità. Essere primus inter pares non ha mai appagato una ambizione, soprattutto quando pares sono tutti gli altri. L'unica eccezione è Cornali, che al mio fianco, nella seduta dello scrutinio, mi chiede, quando si è prossimi al nome della ragazza:
«Ma tu capisci qualcosa quando parla?»
«Sì, tutto» rispondo pacatamente.
«Come tutto?» replica. «Ma allora io sono sordo!» «Può darsi» rispondo, gettandogli una occhiata.
«Ma smettila!» esclama. «Siamo seri! Di' che capisci una parte.»
«Quasi tutto.»
Introduco la correzione del quasi, sempre preziosa per la credibilità del tutto.
Lui scuote la testa:
«Io non le do la sufficienza.»
«Perché?»
«Perché non la capisco» risponde reciso. «Non capisco che cosa dice. Sarà un limite mio.»
«Certamente.»
«Comunque abbiamo tutti i nostri limiti. Lei ha i suoi, io i miei.»
«Non puoi fare qualcosa per superarli?»
«L'ho fatto, credimi» mi dice contrito.
Aggiunge:
«Non ci riesco. È una bella disgrazia.»
«Quale?»
«Avere un difetto come il suo. Non so come chiamarlo, se atonia, afasia, timidezza, blocco emotivo.»
«Sai qual è la vera disgrazia?» rispondo, senza smettere di guardare avanti, verso la finestra chiusa dalle inferriate. «Avere una testa come la tua.»
Non replica. Lo sento alla mia sinistra respirare con più affanno. Finalmente dice (e non si capisce se sia una domanda o una intimidazione):
«Stai scherzando, vero?»
«No, non sto scherzando» rispondo serio. «Forse sto esagerando.»
Per prevenire l'ira consigliano di esibire la calma.
«La vera tragedia è la testa» continuo. «L'ha detto anche Cristo. Il male è quello che esce dalla bocca, non quello che vi entra.»
«Lascia stare Cristo!» sibila. «Non sopporto che tu mi parli così!»
È sterminato il numero delle cose che gli uomini sopportano, mentre negano di poterlo fare. Non me ne preoccupo. Sono il doppio di lui come statura e peso. Sento il sangue martellarmi nelle tempie, la bocca asciutta. Arretro idealmente di poco.
«Io non voglio offenderti» gli dico con un tono più basso, quasi fosse una confidenza. «Solo che sarei io l'insegnante all'antica. Me lo rinfacci di continuo. E tu, che cosa sei?»
È sempre bene, attaccando, fingersi aggredito.
Lui approfitta dell'alibi che gli offro e attenua il tono. «Dico che sei troppo esigente.»
«Ma tu che cosa pretendi da una ragazza handicappata?»
Forse è la prima volta che uso l'aggettivo, destinato in futuro a condizionare la mia vita. Temo di averlo pronunciato con quella indignazione oratoria tipica di chi non ne è coinvolto (ne fanno largo sfoggio politici e letterati). Lui infatti reagisce con brutale noncuranza:
«Macché handicappata! È immatura! Il suo comportamento lo dimostra! Non dobbiamo incoraggiare chi ha un difetto, dobbiamo stimolare a vincerlo!»
II preside, al di sopra delle lenti, guarda nella nostra direzione. È un uomo paziente, mite, studioso di Zanella, a sei mesi dalla pensione: quarantatré anni di scuola gli hanno insegnato che nel rispetto della disciplina c'è una parola superflua ed è disciplina. Rispetto basterebbe.
«Ci scusi» gli dico, anche a nome di Cornali.
Lui annuisce, riportando gli occhiali in cima al naso.
Sento che quel ci è stato un pronome lenitivo per Cornali. Il complemento oggetto ci ha uniti, sia pure grammaticalmente. Ma la grammatica agisce più di quanto pensiamo su ciò che ci resta di oscuro nell'inconscio.
Con voce quasi impercettibile, non molto dissimile da quella della ragazza, gli sussurro:
«Mi spiace di averti parlato così.»
Lui fa cenno di sì con la testa, finse perché non vuole commentare o forse perché non vuole inquietare il preside. Aggiungo:
«Scusami.»
Lui stringe le labbra pensieroso. Immagino che si ritenga risarcito e soprattutto esentato da un seguito problematico delle ostilità.
Commetto un errore:
«Che voto le dai?»
«Quattro» mi risponde.
La lotta per salvare la ragazza dalla condanna si protrasse per mesi (uso il passato remoto che riservo agli eventi storici, almeno nella mia grammatica privata). E si inserì in una campagna più vasta, condotta da Cornali contro il mio metodo di insegnamento.
Carnali si considerava l'araldo di una pedagogia nuova. Proprio lui che umiliava, inventandosi una sordità, chi era già umiliato dalla sorte, proclamava di agire perla liberazione degli studenti. Aveva proposto e ottenuto - non senza l'opposizione tacita dei più sensibili - di farsi contraccambiare il tu. Molti del resto pensano che l'uguaglianza riguardi anche la grammatica dei pronomi. E non hanno tutti i torti. Ma spesso vorrebbero liberarsi anche della grammatica.
Chiedendo agli studenti di considerarlo un coetaneo, Cornali li metteva in imbarazzo, dati i trent'anni di differenza. Assomigliava a quei genitori che si professano amici dei loro figli, illudendosi di condividere con loro non solo i giochi, ma l'età.
In passo successivo era stato di sostituire il voto dell'insegnante con quello dello studente. Un esperimento che io stesso avevo abbandonato, il secondo anno di insegnamento, dopo averne constatato i pericoli: gli studenti più consapevoli e orgogliosi, tentati da fiere autolesioni, si assegnavano il voto più basso. Quelli più furbi e ilari, il più alto. E tutti eravamo insoddisfatti, la classe e io. Cornali invece, saltando la verifica dell'esperimento - fase di cui gli ideologi non hanno alcun bisogno era addirittura passato alla sua correzione. Correggeva infatti, migliorandoli, tutti i voti, gratificando tutti: sia i più preparati, che passavano dal loro sei, quaresimale e punitivo, a un otto entusiasta, sia i meno meritevoli, che arrivavano a una qualificazione generosa. La sua classe, popolata di geni in atto e di talenti in ombra, era stata sollevata e quasi travolta da una ondata di euforia. Lo apprendevo da lui stesso, che faceva confronti con la mia classe.
«Vedi» mi diceva con l'aria pacata e meditativa degli aggressori occulti. «Tu dai del lei agli studenti e lo capisco, perché sei molto più giovane di me e hai bisogno di distanza, che scambi per autorità. Ma io alla mia età posso permettermi il tu, perché non devo simulare l'autorità. Io ce l'ho e ci rinuncio.»
Era una di quelle menti in perenne effervescenza, in cui le idee ribollono e si rimescolano, gestite da una cucina irresponsabile. I singoli ingredienti sono apprezzabili, il sapore è gradevole, ma l'insieme è incommestibile.
«So che tu tieni alla disciplina» aggiungeva. «E anche questo è un segno della tua vecchiaia precoce. La disciplina è una eredità autoritaria.»
«No» gli dicevo. «È il contrario. È autoritario il caos della tua classe, dove chi ha la voce più alta domina gli altri. Io pretendo che, quando spiego o qualcuno domanda, gli altri possano sentire. Altrimenti vadano altrove.»
«Lo vedi che sei un insegnante all'antica?» replicava lui, come se scoprisse un criminale. «Tu pretendi il silenzio.»
«Certo» rispondevo. «Come un pianista. Io per suonare e gli altri per sentire.»
«Quello che mi meraviglia» aveva concluso lui, pensieroso, «è che gli studenti ti rispettino. Eppure tu sei troppo esigente»
Mi guardava, nella confusione radiosa delle sue idee, con uno stupore autentico. Non immaginava infatti che gli studenti mi seguissero anche per questo. Né lo faceva riflettere il crollo delle classi dove la disciplina era crollata e il preside non ne colpiva più le violazioni.
«Anzi!, esclamava. «Una conferma di più! l'autorità, la superiorità riconosciuta di cui parla Horkheimer, non ha bisogno di coperture!»
(E chi non ha autorità, pensavo, che cosa deve fare?)
La sua logica perversa, la sua ragione parziale che pretendeva di essere totale, generava nuovi equivoci. Che io ottenessi ascolto senza minacce né sanzioni, lo confortava a negarle - in nome di un criterio falsamente paritario - a tutti gli insegnanti. Finiva così per giustificare l'indisciplina, infierendo contro i colleghi che non erano capaci di reprimerla.
«Una ragione ulteriore per garantirli» gli obiettavo. «Se non sanno imporsi dobbiamo lasciarli in balia della classe?»
«Peggio per loro» mi diceva, con una ferocia lampeggiante negli occhi.
«E la loro materia» gli chiedevo, «chi la impara?» «Nessuno» mi rispondeva impavido.
Così infatti avveniva. Non si trattava del suo futuro. È questa la verità cinica che misi è fatta chiara nel corso degli anni. Anche se cinico è un aggettivo che viene spesso riservato non a chi incarna un comportamento, ma a chi lo denuncia.
Classi intere disertavano, materialmente o idealmente, interi corsi. Si udivano, passando in corridoio, professoresse che gridavano non per impetrare silenzio, ma per sovrastare le urla. A volte riuscivano improvvisamente a ottenerlo, perché gli alunni si lasciavano scuotere da quelle invocazioni, tra esasperate e stridule.
Cornali, più che parteggiare per gli studenti, si accaniva contro le colleghe. La sua captazione rabdomantica delle cause sbagliate gli faceva infatti trascurare le ragioni più importanti e condivisibili di quella generazione in rivolta: benché nella nostra scuola ne arrivassero solo echi fiochi e attutiti. La mia posizione, ora di adesione ora di dissenso, gli appariva, anziché una scelta problematica, una strategia prudente. Una volta mi aveva accusato perfino di intelligenza. Un'altra mi aveva rimproverato la capacità analitica, ritorsione tipica di chi è sprovvisto anche di quella sintetica. Il suo contributo più consistente al rinnovamento della scuola era stato lo sgretolamento della disciplina. Non so come sia la situazione oggi, ho lasciato l'insegnamento da troppo tempo. Temo sia, sotto questo aspetto, peggiorata, perché allora l'indisciplina era rivoluzionaria, oggi è istituzionale. Gli insegnanti più capaci la neutralizzano prodigando la propria passione didattica. Non sono la maggioranza. Gli altri, abbandonati da terra in alto mare, si comportano come è inevitabile in caso di naufragio: alleggeriscono il carico. Pretendono sempre di meno e così almeno nei documenti burocratici, diventati il sacrario della nuova scuola - ottengono sempre di più. Non c'è come abbassare il metro di valutazione per innalzare il profitto di una classe: compromesso spesso taciuto dalla umiliazione dei docenti quanto ignorato dalla inesperienza degli alunni. Questo almeno mi confessa qualche insegnante sincero, a meno che io frequenti cattive compagnie.
Cornali, che caldeggiava l'abolizione del voto di condotta (una istanza che il futuro avrebbe reso superflua), aveva introdotto nel suo corso una innovazione: lo studio regressivo della storia dell'arte, dal Novecento fino alla età della pietra. Che sarebbe come suggerire a qualcuno, per rendere più spedito il percorso, di camminare all'indietro. Gli alunni avevano dapprima aderito con curiosità, attirati dalla novità della proposta Poi si erano accorti che l'andatura era più lenta, esigeva soste continue e ricognizioni nei due sensi per non incespicare. Ma ormai era troppo tardi per ritornare all'antico.
«Io non voglio fare confronti» mi diceva, come premette chi si accinge a farli. «Ma la tua classe ti obbedisce, la mia mi segue. Tu incuti soggezione negli studenti, io simpatia. Io li faccio sentire geni, tu lavoratori.»
Lo ascoltavo divertito, c'era un calore genuino nel geyser delle sue idee, che appariva il tratto più simpatico del suo carattere. Si considerava, e amava ripeterlo, un creativo, dote che lo autorizzava a proporre le ipotesi più improbabili e a cancellarle lui stesso con un gesto della mano, come follie di un genio mondano in libera uscita. Una citazione dei Veda, una frase di Lao-tzu, una massima di Confucio davano alle sue parole, almeno nelle sue intenzioni, il passo fluttuante di una danza orientale. E l'impressione in effetti era di leggerezza, purché non si indugiasse su quello che diceva. Come molti cosiddetti creativi aveva più interesse per la creazione che per il suo oggetto. Solo che alla fine voleva l'applauso per quest'ultimo (e non gli mancava). Nella sua singolarità era un prodotto in serie, tipico della nostra società, ma non lo sapeva. Probabilmente avrebbe avuto orrore a rispecchiarsi in un suo simile, prova che la vita gli aveva risparmiato.
«Nove mesi per fare un bambino» gli rispondevo con deludente monotonia. «E la scuola dura nove mesi. Vedremo alla fine chi avrà ragione.»
«E come farai a stabilirlo?»
«La reazione della classe. È il test migliore.»
Alla fine il maestro aveva avuto, prima degli scrutini, un coup de theatre. Aveva comunicato a ogni studente il voto che avrebbe ricevuto e svelato contemporaneamente i rapporti di scala: ai più bravi aveva riservato i voti più bassi (per non avere impiegato al meglio i talenti posseduti), ai più deboli i voti più alti (per premiare i loro sforzi).
La classe reagì nel modo che chiunque, tranne il profeta, poteva prevedere: con un silenzio attonito, una catastrofe emotiva. Sgomenti, costernati, a testa bassa, conoscendo i miei conflitti con Cornali, gli studenti erano venuti da me a chiedere conforto. I migliori non sapevano riaversi dall'ingiustizia di una classificazione inferiore a quella dei peggiori. Cornali se li era figurati - con la depravazione immaginativa ricorrente negli ideologi - del tutto insensibili al voto. Ora trovare un giovane insensibile al voto è altrettanto raro che trovarne uno insensibile al denaro. Quanto agli insufficienti, Cornali li aveva previsti raggianti per l'agognato salto di qualità. E in effetti un sei li avrebbe appagati, ma l'otto li aveva avviliti, equiparandoli a inetti da gratificare senza misura e senza speranza. Il più deluso era comunque Cornali, stupefatto che la nuova generazione non generasse un uomo geneticamente diverso dalla sua.
La sua visione della Storia lo induceva a immaginare l'uomo nuovo come uno di quei mostri extraterrestri che hanno il cranio enorme e le gambe filiformi. La testa doveva infatti accumulare l'esperienza dei millenni, mentre il corpo replicava la fragilità del bambino. Scoprire invece che ricominciavano daccapo gli aveva fatto vedere nella luce del tramonto quel mondo che gli altri vedevano nella luce dell'alba.
L'aspetto più sconcertante della sua condotta, alla fine di quell'anno turbolento, era stato il suo accanimento contro la ragazza. L'energia con cui difendeva il diritto dei disabili era pari alla ostinazione con cui la perseguitava. Per lui però non c'era contraddizione. Era convinto che la ragazza non fosse disabile. Aveva riluttanza a credere ai disturbi della mente, forse perché se ne sentiva minacciato. E tendeva ad attribuire a una volontà inerte, a una pigrizia innata, a una viltà occulta l'incapacità di superarli con la ragione. Soffriva di una distorsione duplice nello sguardo, scambiando i sintomi per scelte volontarie e pensando che una punizione motivata li avrebbe esorcizzati per sempre.
Avevo ulteriormente riflettuto, frequentandolo all'interno della scuola sul tema delle contraddizioni. Ed ero arrivato alla conclusione che comunque per gli uomini le contraddizioni non esistono. Esistono sul piano verbale, esistono sul piano logico-matematico. Ed è innegabile che gli uomini possono dire una cosa e farne un'altra, ma nella loro mente non esistono contraddizioni. Le persone più miti e i criminali più crudeli possono ricorrere, è vero, al principio di contraddizione per giustificare i loro errori, ma la loro condotta si potrà finalmente capire solo rinunciando a quel principio: se si cercherà una coerenza inafferrabile, una finalità ignota, una coazione irresistibile. Alla fine l'azione non apparirà contraddittoria, ma necessaria: e il principio di contraddizione, applicato in quel caso, assurdo.
Non sto parlando della ragione di Cartesio. Né della regione in cui i viaggiatori del sogno si perdono e si ritrovano. Sto alludendo piuttosto all'individuo, cioè al nucleo più misterioso e più oscuro, e alla veglia delle sue parole.
La ragazza aveva capito che Cornali, difendendo i disabili e accusando lei, non era vittima delle contraddizioni, ma le piegava a un volere incoercibile. Usava, per conseguire questo risultato, l'arma più losca e più efficace, la ragione. E alla fine aveva ottenuto che lei si rifiutasse di rispondergli, chiudendosi in un mutismo colpevole e senza varchi. Lui me lo aveva raccontato con un'aria di trionfo, come la conferma definitiva della sua immaturità. È curioso che il concetto di maturità sia quello più invocato dalle persone immature. Ma anche qui si tratta di una contraddizione apparente: in realtà, accusando l'immaturità degli altri, difendono la propria.
La ragazza aveva rinunciato, nell'ultimo mese, a studiare la materia insegnata da Cornali. Seguiva con un interesse silenziosamente polemico le sue lezioni, anche perché lui era tra i pochi che sapevano tenerle. Non vorrei contraddirmi, verbo fatale, con quanto ho detto prima, ma Cornali era una mente squarciata da lampi di intelligenza non meno che di idiozia. Anche per i disabili, che allora venivano semplicemente respinti dalla scuola, si era accanitamente battuto per farli accettare. E stato in quel periodo che, sia pure tra sopraffazioni e violenze, si è per la prima volta affrontato, in modo radicale, il nodo della integrazione. Questo non si deve dimenticarlo, in un'epoca che fa dei continui bilanci l'occasione di nuove iniquità e discriminazioni.
Allo scrutinio finale, quando arriviamo al nome della ragazza, Cornali non esprime un giudizio. Ognuno di noi la sostiene con argomenti corroboranti, lui tace. II preside, che cerca di conservare nel lei dedicato a ogni insegnante gli ultimi lembi dell'autorità, gli si rivolge con pazienza:
«Ci dica almeno il suo voto.»
« Promossa», risponde Cornali.
(Brano tratto dal romanzo Nati due volte, Mondadori editore, Milano, 2000.)

Giuseppe Pontiggia è nato a Como nel 1934 ed è morto a Milano nel 2003. Ha scritto tra l'altro La morte in banca, Vite di uomini non illustri, La grande sera e Le sabbie immobili.
  Precedente Successivo Precedente Successivo  Copertina Copertina
|